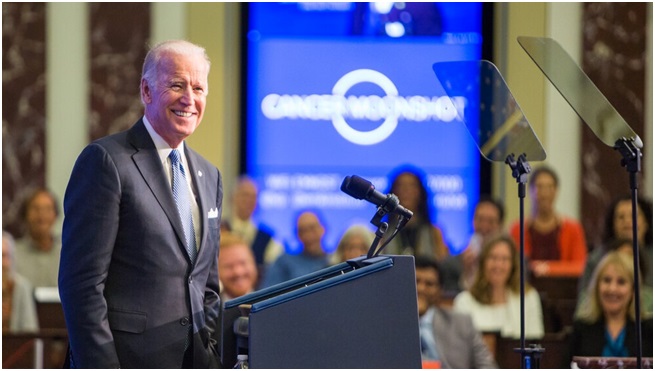Archiviato definitivamente il fallito tentativo dell’amministrazione uscente di sovvertire l’esito del voto, tra pochi giorni Washington vedrà l’inaugurazione della presidenza Biden. Il successore di Trump erediterà la guida di un popolo profondamente colpito dalla pandemia, sia a livello psicologico che economico, e lacerato dalle crescenti tensioni sociali. Puntualmente, ad ogni cambio della guardia, a Washington analisti e policy makers si interrogano sulla possibile strategia di politica estera che verrà adottata dalla presidenza nei diversi quadranti geopolitici, tra cui il Medio Oriente.
Nei prossimi quattro anni la Casa Bianca adotterà un approccio differente nelle relazioni con gli altri Stati, puntando su uno stile di comunicazione più tradizionale e maggiormente improntato al dialogo. Verrà inoltre accantonata la retorica isolazionista, grazie alla quale Trump ha conquistato la Casa Bianca, ma che ha dovuto ben presto abbandonare, anche per gli eventi occorsi nello stesso Medio Oriente. Pur distinguendosi da quella del suo predecessore, la politica estera di Biden manterrà comunque un carattere assertivo.
Qualsiasi forma adotterà la dottrina Biden in Medio Oriente, questi dovrà fare i conti con l’impegno della Russia nell’area. Mosca, negli ultimi anni, ha infatti suggellato il ritorno sul palcoscenico della propria potenza inaugurando una politica mediorientale di successo. Il Cremlino ha riallacciato i rapporti con numerosi Paesi della regione, mettendo alla prova il ruolo predominante degli Stati Uniti. Resta dunque da domandarsi come si evolverà il confronto tra le due potenze nell’area.
Israele e Palestina
Il superamento della presidenza Trump metterà un freno alla “bonanza” che Israele ha conosciuto negli ultimi quattro anni. Il supporto incondizionato maturato in anni di costanti contatti diplomatici, i riconoscimenti dall’immensa portata pratica e simbolica, come il trasferimento dell’ambasciata a Gerusalemme e la legittimità degli insediamenti, ma sopratutto la sponsorizzazione di una campagna di normalizzazione delle relazioni tra il mondo arabo e lo stato ebraico hanno sancito su carta un processo già ampiamente in atto nella regione.
Nonostante l’allontanamento dal massimalismo trumpiano e una possibile uscita di scena di Netanyahu, l’amministrazione Biden perpetuerà lo status quo avallando le iniziative repubblicane. L’unica reale differenza consisterà nel rilancio pragmatico e cauto di una diplomazia multilaterale con la probabile offerta di una stampella all’isolata leadership palestinese. In tale contesto, potrebbe dunque emergere uno spazio di manovra per la Russia, che può vantare cordiali relazioni sia con Israele che con Ramallah, grazie al suo approccio pragmatico e multivettoriale di politica estera.
La vicinanza del Cremlino a entrambe le fazioni è il frutto di una ben precisa strategia, che da un lato ne plasma l’identità di partner politico imparziale e gli permette di perseguire obiettivi a lungo termine, dall’altro invece prova a indebolire la credibilità degli Stati Uniti e dei suoi alleati. La Russia potrebbe dunque porsi alla guida di iniziative di pace alternative e sfruttare la sua influenza in Siria per aumentare la pressione su Israele, nel momento in cui quest’ultimo decidesse di procedere con annessioni unilaterali o violazioni del diritto internazionale.
Siria
Nel conflitto che dal 2011 interessa la Siria, l’amministrazione Trump ha adottato un approccio contraddittorio che ha conseguentemente rafforzato l’iniziativa di Russia e Iran intervenute a puntellare la declinante autocrazia. Proprio in Siria, tramite l’intervento militare diretto, Mosca ha inaugurato un ritorno assertivo nella regione, assicurando non solo la sopravvivenza di un alleato ma anche la sussistenza della base mediterranea a Tartus, storicamente in mano al Cremlino.
L’amministrazione Biden presumibilmente agirà dedicando maggiori energie alla ricerca di una soluzione politica, e respingendo un eventuale normalizzazione dei rapporti con il regime. Da candidato, Biden si è dichiarato contrario al ritiro del contingente statunitense dalla Siria ed ha attaccato il presidente uscente per aver abbandonato gli alleati curdi. Anthony Blinken, il principale consigliere di politica estera di Biden e prossimo Segretario di Stato ha inoltre dichiarato nel corso di un’intervista che, con la nuova presidenza, gli Stati Uniti manterrebbero una presenza militare nel nord-est della Siria. E molto probabilmente anche la continuazione di uno status quo che contenga le iniziative russo-turco-iraniane nel rebus siriano.
Turchia
Nell’ultimo periodo le relazioni tra Turchia e Stati Uniti hanno visto un rapido peggioramento, accelerato dalla decisione americana di imporre nuove sanzioni per l’acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico russo S-400. Il vero oggetto del contendere è pero l’assertività della Turchia, impegnata in una politica estera proattiva dal sentore imperiale. Dal Caucaso alla Libia, Erdogan ha rilanciato la nazione nel palcoscenico globale conseguendo importanti risultati e allarmando Washington. La personale empatia fra Trump e il rais turco ha permesso al secondo una certa libertà di manovra che potrebbe tuttavia venir meno con l’uscita di scena del tycoon.
Dall’abbattimento nel novembre 2015 di un caccia russo da parte della contraerea turca al recente appeasement in Caucaso, tra Turchia e Russia si sono succedute crisi e riappacificazioni sfociate in un matrimonio di convenienza che ha permesso la risoluzione di controversie apparentemente inestricabili. I due Paesi, storicamente agli antipodi, sono riusciti a “compartimentale” le loro differenze per evitare qualsiasi ricaduta diplomatica. La relazione difficilmente potrà evolversi verso una vera e propria alleanza. Allo stesso tempo però, Mosca e Ankara, sfruttando l’assenza dell’Europa, continueranno a spartirsi sfere di influenza in ogni conflitto in cui si troveranno contrapposte.
Che tra Biden e il rais turco non corra buon sangue non è affatto un mistero. In quanto alleati nella Nato, gli Stati Uniti continueranno a sostenere la Turchia, ma il futuro presidente USA cercherà anche di aumentare la pressione per imporre il rispetto dei diritti umani. Non mancheranno occasioni per far tornare in superficie i nodi che hanno macchiato la relazione. Ciononostante, vi saranno altrettante spinte istituzionali in favore del mantenimento di rapporti saldi con un importante alleato che potrebbe avvicinarsi sempre di più all’orbita russa.
Libia
In seguito al coinvolgimento della Nato nel rovesciamento di Muhammar Gheddafi, gli Stati Unitihanno intrapreso la strada di un progressivo sganciamento dalla Libia, tentando disostenere gli sforzi per risolvere la crisi senza rivendicare un ruolo primario. La presidenza Trump tuttavia si è posta in netta contraddizione rispetto alle intenzioni di un’Europa frammentata nel supportare il governo di Tripoli. Trump ha mostrato una certa compiacenza nei confronti del generale Khalifa Haftar, che ha potuto disporre di una luce verde per provare a chiudere il conflitto conquistando la Tripolitania.
L’assenteismo occidentale ha permesso alla Russia di impiantare una formidabile rete militare nel Mediterraneo. Rete che trova un importante perno nella Libia travolta dalla guerra civile. Putin ha scommesso sull’Esercito Nazionale Libico (LNA) di Haftar che ha ricevuto pari sostegno dall’Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti e, più discretamente, anche dalla Francia.Se Mosca riuscisse a rafforzare la sua posizione in Libia nel lungo termine, otterrebbe una leva significativa sull’Europa e un ulteriore accesso al Medio Oriente e all’Africa.
Il neoeletto presidente americano potrebbe intraprendere un approccio più coerente, mirando alla riduzione dell’influenza russa in Libia. Ciò sarebbe possibile attraverso l’imposizione di sanzioni che andrebbero a fare pressione sugli alleati di Haftar, i quali hanno favorito l’ingresso di Mosca in Libia. In aggiunta, l’amministrazione democratica continuerà a sostenere il processo politico volto a portare stabilità e sicurezza nel Paese e a perseguire i responsabili di crimini, tra cui lo stesso Haftar.
Iran
Uno dei temi su cui Trump ha preso maggiormente le distanze da Obama è l’Iran. Il tycoon ha ribaltato l’approccio del predecessore che aveva portato alla firma di uno storico accordo sul nucleare. Al posto di cercare il dialogo con la parte più moderata del regime iraniano, Trump ha preferito implementare una strategia di “massima pressione”. Secondo il nuovo piano, le ulteriori sanzioni imposte sull’economia del Paese e il suo conseguente isolamento avrebbero spinto il regime iraniano al collasso, oppure ad un accordo in cui avrebbero prevalso le condizioni americane. Eppure, Il regime ha mostrato notevole resilienza attraverso il rafforzamento della componente conservatrice della Repubblica Islamica e un maggiore impegno nella realizzazione del progetto.
Grazie al nuovo consolidamento dell’establishment iraniano, nel caso in cui Teheran decidesse di tornare al tavolo della trattative si troverebbe in una posizione di forza rispetto all’amministrazione entrante. In continuità con la strategia di Obama, Biden ha costantemente sostenuto l’accordo sul nucleare e si è sempre detto contrario all’approccio di Trump. Tuttavia, attualmente i rapporti tra Iran e Stati Uniti sono pessimi, e non sarà così facile riallacciarli. Come se non bastasse, la vittoria dei conservatori alle elezioni presidenziali iraniane di giugno potrebbe inoltre cambiare l’identità dei negoziatori irrigidendo ulteriormente un clima già molto teso. Gli Stati Uniti dovranno dunque proseguire il percorso verso l’interruzione del programma nucleare e missilistico, favorendo la riapertura degli scambi economici e il riconoscimento del ruolo di potenza regionale dell’Iran.
Il Cremlino potrebbe porsi alla guida di nuovi negoziati sul programma nucleare di Teheran. I due Paesi hanno infatti numerosi obiettivi comuni nella regione, tra cui la sopravvivenza del governo Assad, lo sviluppo di sfere di influenza in Eurasia e l’approfondimento della cooperazione in ambito commerciale. Condividendo un sentimento di ostilità verso Washington, Russia e Iran hanno visto una notevole convergenza strategica che difficilmente si evolverà in un’alleanza vera e propria, ma che di per certo ha incrementato il dialogo bilaterale. Da parte sua, Mosca vorrebbe che Teheran riacquistasse legittimità internazionale e tornasse ad essere un attore geopolitico “spendibile”. L’Iran, a sua volta, gioverebbe dalla possibilità di poter contare sul Cremlino in caso di lunghe trattative verso un nuovo accordo, diminuendo il rischio di decisioni sfavorevoli in seno al Consiglio di Sicurezza e lenendo la crisi dovuta all’isolamento internazionale.